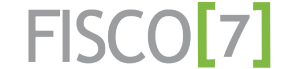La disciplina degli studi di settore è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.
Gli studi di settore rappresentano, al tempo stesso, una procedura di calcolo su base statistica per la ricostruzione induttiva dei ricavi e compensi nei confronti dei soggetti con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 7,5 milioni di euro e una procedura di accertamento, previo contraddittorio, che può prescindere dalle risultanze delle scritture contabili.
I maggiori ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono, infatti, presupposto per l’accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.
L’aspetto critico dello strumento è rappresentato dal suo carattere ipotetico, presuntivo, di supporto all’accertamento che può condurre a distorsioni se inteso come uno schema fisso da utilizzare direttamente per la ricostruzione degli imponibili.
Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate ha cambiato indirizzo e con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 ha riconosciuto che il peso del responso di Gerico ha il peso di una “presunzione semplice” (circolare 5/E del 2008), piuttosto che quello di una “presunzione legale relativa” (circolare n. 58/E del 2002), con ciò escludendo qualsiasi attività accertativa fondata esclusivamente sullo scostamento tra la funzione di ricavo e la situazione reddituale dichiarata dal contribuente.
Tale impostazione risulta confermata dalla recente giurisprudenza della Cassazione, la quale con sentenza delle SS.UU n. 26635 del 18 dicembre 2009 ha affermato che la mancata congruità degli Studi di settore deve essere confrontata con altri elementi idonei a fotografare l’effettiva situazione del contribuente e comunque non è sufficiente a far scattare l’accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le indagini volte a ricostruire il reddito si basano su una mole sterminata di banche dati, dall’anagrafe tributaria a quella dei conti correnti, e così qualcuno deve essersi chiesto perché non mettere le informazioni proprie del redditometro per valutare la situazione economica di chi risulta incongruo alla prova degli studi di settore.
Il redditometro, in particolare, si serve di una serie di indicatori che consentono di presumere l’effettiva capacità contributiva del cittadino.
Agli indicatori tradizionali (case, auto, imbarcazioni, cavalli, personale domestico, ecc.) negli ultimi tempi ne sono stati aggiunti ed elaborati di nuovi (viaggi, iscrizione dei figli a scuole private, frequentazione di club esclusivi, acquisto di opere d’arte, ecc.) e altri sono in arrivo per l’applicazione del nuovo redditometro così riscritto dall’art. 22 del D.P.R. n. 78/2010.
Perché, dunque, rinunciare a questo patrimonio d’informazioni nei confronti d’imprenditori e professionisti che sforano i risultati degli studi di settore?
Le presunzioni provenienti dall’utilizzo del redditometro potrebbero dunque essere utilizzate come la prova mancante per completare il cerchio e blindare l’accertamento da ogni contestazione anche se è doveroso sottolineare che la combinazione studi di settore-redditometro potrebbe avere un’elevata forza probatoria soltanto se l’unico reddito del contribuente persona fisica sia quello derivante dall’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, atteso che l’accertamento sintetico consente di determinare il reddito complessivo netto del contribuente (calcolato quindi tenendo conto delle varie categorie reddituali – fondiari, lavoro dipendente, impresa, capitali, ecc…- attribuibili al contribuente), mentre gli studi di settore consentono di stimare soltanto i ricavi o compensi della sua attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.