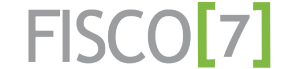Il lavoro ripartito (o job sharing) è stato previsto dall’art. 41 del D.Lgs n. 273/2003 come una forma contrattuale che prevede la distribuzione della prestazione lavorativa di due lavoratori, su un orario ridotto, modulato o flessibile. In effetti, con lo job sharing due lavoratori si co-obbligano per l’adempimento di una sola e unica obbligazione lavorativa: in pratica, la prestazione lavorativa è una, i lavoratori sono due e sono accumunati da un vincolo di solidarietà. Ma come mai in Italia non si è diffusa questa forma contrattuale?
I lavoratori infatti sono liberi di ripartire l’obbligo lavorativo tra di loro sostanzialmente come vogliono (pur con comunicazione al datore di lavoro), ma il datore di lavoro rimane tutelato dal vincolo di solidarietà che esiste tra i due dipendenti. Fatta salva diversa intesa fra le parti, infatti, ciascun lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’intera prestazione lavorativa: nel caso di impossibilità allo svolgimento della prestazione da parte di uno dei soggetti, quindi, l’altro eseguirà per intero l’obbligazione assunta nei confronti del datore di lavoro (salvo che non sia stato previsto l’intervento di un terzo contraente eventualmente obbligato alla prestazione).
Il lavoro ripartito è differente dal lavoro part-time sostanzialmente per due aspetti: il lavoro ripartito non è costituito da due distinti rapporti di lavoro part-time, essendo ogni lavoratore in esso coinvolto obbligato in solido per una intera prestazione lavorativa. Inoltre, nel lavoro ripartito (fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi) i lavoratori possono determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro o modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro. Nel lavoro part-time è il datore di lavoro che invece stabilisce la distribuzione dell’orario di lavoro (fatto salvo il consenso del lavoratore).
A ben vedere, quindi, con il lavoro ripartito è stato creato uno schema contrattuale che contempera le esigenze di flessibilità dell’impresa con la gestione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, con una formula che bilancia la discrezionalità dei lavoratori di determinare l’organizzazione della prestazione lavorativa internamente, con la garanzia per il datore di lavoro rappresentata dal vincolo solidaristico in capo ai dipendenti.
Ma quindi, cos’è che ha impedito il diffondersi di questa forma di organizzazione del lavoro in Italia?
Un primo aspetto è relativo proprio al vincolo che lega i due soggetti: è essenziale l’esistenza di un solido vincolo fiduciario tra i due, dovendo rispondere i lavoratori per l’intera prestazione lavorativa nel caso di impossibilità dell’uno o dell’altro ad eseguirla, ma altresì per la pianificazione della ripartizione del lavoro su cui devono convenire.
Un altro versante di criticità attiene invece alla gestione del rapporto di lavoro dal punto di vista aziendale, sostanzialmente legati al raddoppio dei costi amministrativi e di inserimento delle risorse. Il profilo più rilevante, ad ogni modo, pare in qualche misura legato all’aspetto più sopra descritto di un buon vincolo esistente tra i due co-obbligati. Disallineamenti o incomprensioni tra i lavoratori coinvolti, infatti, possono comportare disservizi nell’organizzazione e nel regolare svolgimento dell’ attività aziendale: tra questi, i black-out nella comunicazione appaiono tra le problematiche più frequenti che inibiscono la fiducia nei confronti di questo schema contrattuale.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN