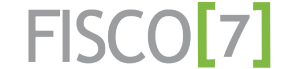In questi giorni la discussione sulla rivisitazione dell’articolo 18 è al centro dell’attenzione e del dibattito politico e mediatico. Si assiste ad un confronto acceso sul “se” e sul “come” il Jobs Act (atto secondo) interverrà su tale norma storica del nostro sistema giuslavoristico. Si ascoltano opinioni ed opposizioni sulla opportunità o meno di mettere le mani su tale norma. Si prendono posizioni. Si assumono decisioni. Occorre però innanzitutto capire di cosa stiamo parlando.
Non si vuole qui entrare nel merito delle misure modificative in corso ma effettuare una puntualizzazione in merito alla funzione che viene attribuita all’articolo 18. Ogni giorno si sente parlare dell’articolo 18 come “la norma che vieta i licenziamenti senza giusta causa” e su questo punto è doveroso un chiarimento.
L’articolo 18 fa parte della legge n. 300 del 1970 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” meglio conosciuta come “Lo Statuto dei Lavoratori”) e serve a disciplinare (o serviva, prima che la Riforma Fornero lo spezzettasse in mille ipotesi) le conseguenze per il datore di lavoro in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, all’interno di aziende (sinteticamente) con più di 15 dipendenti (oltre alle specifiche ipotesi regolanti diverse fattispecie).
A chi si accinge a dissertare su un tema così delicato come l’abolizione di una norma in tema di gestione del rapporto di lavoro, occorrerebbe chiarire che è la legge n. 604/1966, che, all’art. 1 prevede che “Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, […] il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo”.
La norma che vieta i licenziamenti in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo esiste pertanto già dal 1966 (se non da prima, cfr. infra). E si applica, sinteticamente, a tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni occupazionali.
Occorre a questo punto effettuare la distinzione tra giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo e giusta causa. In via esemplificativa basterà dire che:
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. art. 3 l. n. 604/1966) attiene ad una condizione produttivo organizzativa dell’impresa (ad es. la chiusura di un reparto produttivo);
- il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (cfr. art. 3 l. n. 604/1966) attiene ad un inadempimento da parte del lavoratore relativamente alla sua prestazione lavorativa, inadempimento tuttavia non così grave da compromettere il vincolo fiduciario che lo lega al datore di lavoro (ad es. un errore nell’espletamento della propria attività);
- la giusta causa (art. 2119 c.c.) attiene ad una causa talmente grave da non permettere la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro, in quanto il fatto compiuto dal prestatore di lavoro è di una gravità tale da compromettere il rapporto fiduciario sotteso al rapporto di lavoro stesso.
Non è l’articolo 18 della L. n. 300/1970, pertanto, che “vieta i licenziamenti senza giusta causa”, come viene da più parti sbandierato in questi giorni. Il concetto di “giusta causa” esiste dal 1942. E non ci pare che il legislatore stia lavorando sul codice civile.
L’articolo 18, ribadiamo, disciplina le conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro che commini un licenziamento dichiarato successivamente illegittimo, per le aziende rientranti nel campo di applicazione in esso indicato e visto più sopra. Una precisazione quanto meno utile, per farsi un’idea in merito a ciò che ci viene raccontato.
Altra questione, poi, è cercare di capire in che modo la modifica dell’articolo 18 sia “in grado di estendere i diritti a chi attualmente ne è privo”. Ma questa è tutt’altra storia.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN